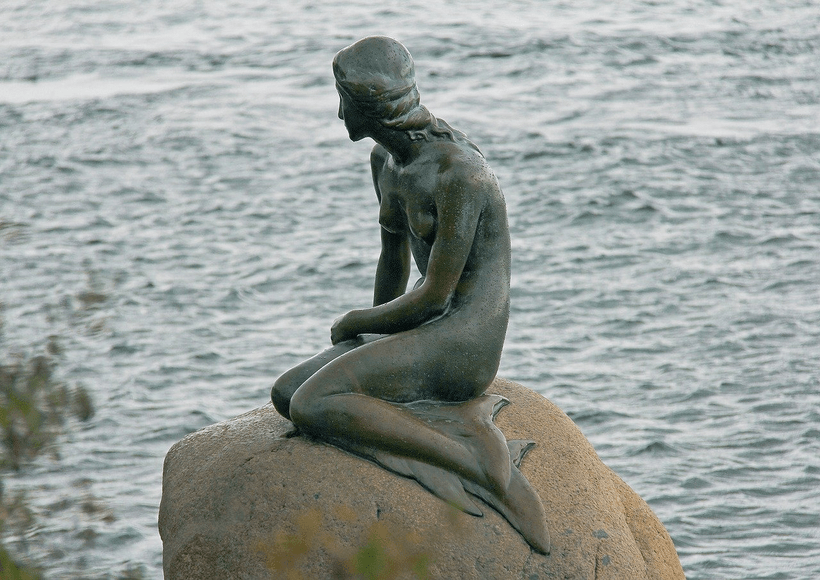Il racconto O FORSE NO? di Alfonso Esposito è tratto dall’antologia ‘Cuore di Cuoio’. I racconti ci terranno compagnia durante i Campionati Europei di calcio.
Con occhi nuovi
Non era una capitale, ma per noi era il cuore del mondo. Altro che le sfavillanti metropoli americane o quelle vecchie città europee grondanti secoli di storia, se volevi dire di aver vissuto dovevi essere nato lì. Aalborg, per chi è come me, è sempre stata l’universo intero, non ci è mai mancato niente. Me lo ha fatto capire un giorno Ole, al rientro dalla lezione di nuoto: “Jesper, oggi in vasca non c’ero proprio…”. “Ma come – gli ho risposto – se non hai fatto altro che schizzar acqua come al solito?!”. “Certo, ma con la testa viaggiavo…”. “E dove ti ha portato? Al Polo? In Africa, tra i leoni e gli elefanti? O nella steppa russa?”, gli ho chiesto deridendolo. “Nemmeno lo immagini”, ha sospirato guardando il cielo. “Nello spazio?”, ho chiesto allora, mentre, un po’ perché faceva il misterioso, un po’ per la fame, iniziavo a seccarmi di quel giochino idiota. “Sono stato…” e con l’indice sinistro che ruotava tutto intorno mi ha fatto capire che non si era mosso da Aalborg.
“Ma sei fuori?” gli ho sghignazzato in faccia. “Qui ci siamo nati, mica vale come viaggio! E poi che avrai visto mai, sappiamo quasi tutto di questa città”. “Eeehhh, questo lo credevo anch’io fino a stamattina… adesso invece sono sicuro che non è così, Jesper…”. A questo punto ho pensato che stesse fuori, forse s’era preso qualcosa prima di venire a nuoto. E già, che suo fratello Martin lo avevano beccato una sera, meglio una notte, che aveva masticato non so che cosa e andava gridando in giro di vedere i draghi… Di certo, non era ammattito per lo studio, Ole imparava quel tanto che bastava per vivacchiare avanti ogni anno, quasi per inerzia. Che avesse una bella testa lo sapevamo tutti, tra di noi tirava fuori certe storie inventate di sana pianta quando, a zonzo per le vie del quartiere, portavamo a spasso la nostra infanzia.
“Insomma, ti decidi a dirmi cosa ti frigge nel cervello?”, gli ho intimato quasi aggressivo, ormai per la fame non ci vedevo più. “Hai ragione ed hai torto, di questa città sappiamo praticamente tutto, ma anche poco o niente” e così dicendo mi ha mandato in bestia. “Ma crepa!” gli ho urlato mentre mi staccavo da lui affrettando il passo. Ole, però, non si è fatto distanziare, mi ha trattenuto per un braccio e, sorridendomi calmo come sempre, si è deciso a svelare il mistero di quel mercoledì pomeriggio. “Pensaci, hai mai contato i gradini che portano alla porta di casa tua? Hai mai notato che, andando a piedi al porto, l’odore di mare e catrame, di alghe, sale ed aringhe affumicate certe volte ti abbraccia già a metà strada? O che intorno all’aeroporto l’erba è di un verde diverso da quello del giardino di casa mia?”. “Veramente, no” gli ho risposto evitando di guardarlo, quasi in colpa, come se mi avesse pizzicato impreparato ad un’interrogazione. “E sai perché non ci avevi fatto caso?”, mi ha incalzato ancora, senza nemmeno darmi il tempo di rispondere, “perché credi che quello che vedi e senti ogni giorno sia finito lì, magari lo rivedi e lo risenti, ma per te è già vecchio, passato…”.
“Ole, dov’è che vai a parare?”, l’ho rimbeccato scorbutico, ma divorato dalla curiosità. “Lo sai che mia nonna sta morendo, vero?”, mi ha sibilato a bruciapelo. “Sì – ho ammesso quasi arrossendo per l’imbarazzo e la vergogna – me lo hai detto dopo che siamo stati a mangiare frittelle da lei due mesi fa…”. Quelle frittelle erano famose almeno quanto la Torre e il Carnevale di Aalborg, che attraeva gente da ogni angolo dello Jutland. La nonna le friggeva facendole affogare nello strutto, le inzuccherava tutte e le allagava di sciroppo di fragola. Erano una festa, sembrava sempre domenica, anche di lunedì. “Come si sente?” gli ho domandato con un filo di voce, e intanto mi maledicevo da solo, “bestia, come vuoi che stia una col tumore?”. “Sta bene…” ha sussurrato come se pregasse. “Bene? Ma lei?”, proprio non credevo che mi avesse risposto così. “Sì. Lei. Perché quando stai per andartene guardi tutto con occhi diversi, nuovi, anche se hai quasi novant’anni. Ieri sera mi sono ricordato che domenica pomeriggio mi ha salutato col solito bacio sulla fronte, dicendomi che non mi aveva mai visto così luminoso, allegro. Al che le ho fatto notare che proprio quel pomeriggio mi sentivo un po’ giù, ancora compiti del lunedì da sbrigare e l’Aalborg aveva pure perso in casa. Ma lei mica si è arresa”. “No?” l’ho interrotto col cuore in gola. “Macché, mi ha inchiodato con un «Io ti vedo così» che mi ha martellato testa e cuore fino a stamattina, quando venendo a piedi mi sono accorto che tutto mi pareva diverso, anche le crepe nei muri della casa del vecchio dottor Henriksen, il prof di Scienze che voleva sapere tutto, pure le virgole del libro, perfino quella casa malandata mi è sembrata non cadente, ma sopravvissuta ad una lotta col tempo, la dimostrazione di una vittoria sofferta. Poi ti ho visto nello spogliatoio, anche il tic che hai di indossare la cuffia sempre dal lato sinistro non l’ho visto più come una fissazione stupida, ma come un gesto familiare, che non potevo giudicare perché apparteneva al mio amico di culla…”. Mi
veniva da piangere, il sangue mi batteva forte in testa, non sapevo che dire. E m’è uscita fuori l’unica domanda che sentivo di rivolgergli: “Stasera vieni a vedere la partita da me? C’è anche Frida…”.
Due, ma uno
Già, Frida. L’unica capace di reggere il confronto con noi del quartiere dello stadio. All’inizio per poco non la picchiavamo, lei era della Gaden, la strada dei pub e dei ristoranti, quella del passeggio e della folla caotica, a noi faceva quasi paura con quel suo parlare a voce alta. Ce la trovammo tra i piedi un giorno quasi per caso. “Ma questa che vuole?” le ha gridato ostile Henke. E lei: “Farti passare tra le gambe quel pallone che hai sottobraccio”. Tutti a ridere, mentre Henke la rimbeccava “Chi, tu? Ma se nemmeno lo vedresti il pallone…”. “Se ne sei così sicuro mettilo a terra e fammi vedere!”, lo ha sfidato Frida. Henke, sempre più simile ad un vulcano in fase di scoppio, tanto gli erano diventate paonazze le orecchie a sventola, non se l’è fatto dire una seconda volta, messo a terra il cuoio l’ha puntata come un toro nell’arena e ha inscenato il suo pezzo forte, avvicinarsi a meno di trenta centimetri, fintare sulla sinistra e buttarsi a destra. Noi, pur conoscendolo da un pezzo, qualche volta ci cascavamo ancora. Frida no, invece. Ferma sul posto non lo ha contrastato, come tutti, allungando la gamba sinistra per stopparlo, ma portando la destra all’indietro e frapponendola a mo’ di barriera di un passaggio a livello. Henke ha fatto un volo di un metro e mezzo buono, mentre tutti lo spernacchiavano e Frida, avvicinandosi beffarda, gli ha teso la mano e gli ha chiesto. “Ora andiamo o no?”.
Da quel giorno non c’era partita o torneo senza Frida. “Come farà ad essere danese, se è scura come un tizzone? E come farà a giocare a calcio così bene?” si ripetevano un po’ tutti. Io, però, lo sapevo il perché. Suo nonno nel Dopoguerra era stato centrattacco del Vejle, segnava pure tanto. Se l’era cresciuta lui Frida, dopo che un infarto s’era portato via il papà. In effetti, come ragazza o donna Frida era strana. Mi piacevano da morire le sue gambe, ma non perché risvegliassero in me chissà quali fantasie erotiche, ma semplicemente perché erano come due rami d’ebano, scuri e compatti, se entrava in tackle ti faceva male per davvero. E quando ci presentavamo con lei a sfidare qualche altra squadretta cittadina, sogghignavamo perfidi quando ci prendevano in giro a causa sua. Dopo la partita, anche se perdevamo, non parlavano più.
Del nonno e del suo amore per il calcio mi ha raccontato tutto lei, una sera d’inizio giugno, quando abbiamo visto insieme un incontro di qualificazione della Danimarca per il Mondiale messicano dell’86. Il pomeriggio prima mi si è avvicinata manco fosse una di quelle fosche spie dell’Est e, a bassa voce, mi ha chiesto: “Domani la vediamo insieme la partita?”. Le ho subito detto di sì, io che di timidezza posso dare lezioni private e pubbliche a tutti. Ancora oggi mi chiedo come mi sia venuta su quella risposta. So solo che quella sera nel salotto di casa dei nonni ho capito davvero cos’è una partita. Il vecchio mi spiegava i movimenti intelligenti di Lerby ed Arnesen (“il nostro Neeskens” lo chiamava), contava i tocchi di prima che proiettavano la palla oltre ogni ostacolo. Li abbiamo stracciati per 4-2, doppiette di Elkjaer e Michael Laudrup. Erano gli albori della Danish dynamite, quella che in Messico ci avrebbero invidiata tutti. Dopo la partita Frida mi fa: “Hai capito perché amo il calcio?”. Avevo capito. Molto bene.
Quel campionato del mondo, il primo in assoluto per la nostra rappresentativa e per noi che l’amavamo, lo abbiamo atteso manco fosse Natale, contavamo i giorni alla rovescia. Naturalmente lo abbiamo vissuto insieme, su mia insistenza anche Ole aveva avuto accesso alla ‘tribuna’ di casa dei nonni di Frida. Tra lei e lui il rapporto era strano, si rispettavano e si temevano, Ole l’ha sempre vista come una ‘femmina sbagliata’, “Cos’ha quella delle donne e della Danimarca?” mi chiedeva qualche volta tra lo scherzoso ed il preoccupato, “assomiglia più ad una tedesca…” aggiungeva con una punta di prosopopea. Io lo lasciavo dire, a me Frida era piaciuta da subito, in lei scoprivo quello che avrei voluto essere, lei lo aveva capito benissimo ed anche per questo si era legata a me. Quando giocava la Nazionale, però, svaniva ogni ombra, anche la più sottile, la ‘dinamite’ del pallone ci faceva esplodere di gioia tutti insieme. L’unico cruccio di Frida e di suo nonno era che Allan Simonsen, l’eroe della patria, l’unico danese ad aver vinto il ‘Pallone d’oro’, scaldasse la panchina. A rubargli la maglia e la scena c’era uno che portava il mio nome, Jesper, Olsen il cognome, a me era simpatico, ma non lo dicevo per non dare un dispiacere ai miei due amici, Frida e il vecchio. Perché eravamo amici.
Un’altra partita
Quel Mondiale si annunciava come il paradiso in terra. Almeno così pareva a me, elettrizzato dalla nazionale e dalla compagnia nella tribuna domestica. Tutto mi sembrava perfetto. Anche perché abbiamo iniziato alla grande, 1-0 agli scozzesi e addirittura uruguaiani polverizzati per 6-1, Elkjaer inarrestabile, quattro centri in due gare, dall’inizio alla fine di ciascuna sfida, intervalli compresi, l’adrenalina era a mille, è stato allora che ho assaggiato per la prima volta un goccio di Gammel Dansk, sono stati Frida e il nonno a convincermi, teneva su, dicevano. Non ricordo nemmeno che sapore avesse, ma in quel momento ho pensato di essere davvero diventato uomo.
Ci aspettava al varco la Germania Ovest, agli ottavi eravamo già passati, ma volevamo giocarceli da primi del girone. Il nonno di Frida, che se la spassava un mondo a vestire i panni dell’esperto di pallone, ci ammoniva che quelli erano duri a morire. Ole strizzava l’occhio e, quando nessuno ci sentiva, mi sussurrava perfido “Scommetto che Frida fa il tifo per loro”, in un angolo del suo cuore lei restava ‘la tedesca’. Ma nemmeno questo mi amareggiava, ero al settimo cielo per quell’estate fantastica. Neppure i crucchi potevano rovinarmela. E così è stato, finirono al tappeto con un mortifero uno-due tra primo e secondo tempo, volavamo ai quarti, malgrado il fantasma di Simonsen volteggiasse imperterrito tra i nostri commenti entusiastici. “Perché non lo manda in campo più spesso?”, chiedeva Frida incredula che fino ad allora gli fosse stata concessa la miseria di soli venti minuti, proprio contro la Germania. “Non è più un ragazzo, da quando si è rotto due anni fa bisogna impiegarlo con attenzione” provava a consolarla il vecchio, ma si vedeva lontano un miglio che lo diceva tanto per dire. Testa alla Spagna, temibile ma non invincibile. Quella sera la nonna di Frida aveva dato il meglio di sé, frikadeller a volontà, quando mangiavo lì la timidezza mi abbandonava e Frida, mentre eravamo soli, me lo faceva notare divertita. Mi piaceva il suo sorriso, lì, in casa dei suoi nonni, ho capito che sorridere e ridere non sono la stessa cosa e che un sorriso è più una questione di occhi che di bocca.
Nulla avrebbe potuto rovinarci la festa. Dopo mezz’ora ha segnato il ‘mio’ Jesper Olsen, 1-0 e goccino di liquore nell’intervallo, per esaltarci ancora di più. Un disastro, invece. Le furie rosse si sono ricordate di essere tali proprio contro di noi, cinque frustate nella ripresa e quattro del loro centravanti, uno che chiamavano sinistramente ‘l’avvoltoio’ ma che Frida, furente, ribattezzò cabròn, imparando l’unico vocabolo spagnolo della sua vita. Una doccia gelida, altro che l’acqua dello Skagerrak in pieno inverno. Di colpo si è sgonfiato tutto, manco parlavamo più. Le parole le avremmo ritrovate, tutte, il giorno dopo. A Frida venne in testa di dire che se ci fosse stato Simonsen, l’unico che conosceva il calcio spagnolo avendoci giocato, sarebbe andata diversamente. “Continua a sognare!” l’ha rimbeccata Ole. “Ma che ne capisci di calcio?!” si è stizzita Frida, “Ne so molto più di te” ha vomitato amaro Ole. Poco c’è mancato che si picchiassero, io fra di loro a chiedergli di calmarsi. Inutile. Mica era il primo litigio per me, ma gli altri al confronto erano bolle di sapone, il tempo di montare in aria che già svanivano. Stavolta non sarebbe stato così, non si sono parlati più. A poco a poco la distanza è diventata silenzio ed io c’ero in mezzo. Ho anche provato a fare da ponte, ma Ole non sopportava che una femmina gli rispondesse così, hai voglia a dire che siamo danesi e, per questo, mentalmente più aperti, una femmina, su certe cose, deve saper stare al posto suo. Frida, poi, peggiore di un mulo, non arretrava di un millimetro. È finita che li vedevo a momenti alterni. Qualche volta s’incontravano alle feste di amici comuni ma, se l’altro non vuole nemmeno guardarti, sei più trasparente di un vetro. Io, però, li vedevo.
Ancora insieme
“Allora, che fai, vieni anche tu?”, ho chiesto ad Ole dopo avergli detto che quella sera, stavolta a casa mia, ci sarebbe stata pure Frida. Lo ammetto, era un colpo basso, approfittavo di quel suo discorso sognatore sul vedere le cose con occhi diversi, del fatto che la malattia della nonna avesse perforato la corazza del suo orgoglio. Sembrava ieri, ma erano passati sei anni. Sei anni, non eravamo più i bambini del quartiere dello stadio, ma ragazzi che studiano da uomini. Tempo un paio d’anni ed avremmo varcato la soglia dell’università, ma in fondo la maturità non è solo l’archiviazione di un percorso scolastico. Ole mi ha fissato per qualche secondo, mi è bastato però per capire che dentro di lui il suo io lottava duramente contro se stesso: che fare? Tenere il punto con Frida o dimostrare che tutto quello che mi aveva detto sulla realtà vista diversamente non erano solo aria fritta?
“A che ora?” ha tagliato corto. “Un’ora prima del fischio d’inizio – ho risposto – ma se vuoi anche cinque minuti…”. “Un’ora va bene” ha sentenziato inespressivo. Aveva funzionato, il merluzzo aveva abboccato. Era bastata l’esca giusta, il suo stesso orgoglio. Ci avessi pensato prima, non sarebbe passato tanto tempo. Ma, da ragazzo con una fantasia limitata allo stretto indispensabile, non avevo saputo far altro che cogliere l’opportunità del ripescaggio della Danimarca agli Europei svedesi di quell’anno, dopo la squalifica della Jugoslavia, martoriata dalla guerra e per giunta esclusa. Non mi sembrava giusto, anche se poi, pensandoci, nemmeno era stato bello che noi perdessimo il biglietto per la Svezia di un solo punto. Il Gud-ballon, il ‘dio-pallone’, come lo chiamava ironico il vecchio nonno di Frida, aveva deciso così. Non che l’inizio fosse stato di quelli memorabili, i nostri già erano in vacanza quando sono stati recuperati, salviamo la pelle nello 0-0 inaugurale con l’Inghilterra di Lineker, ma perdiamo di un gol nel derby scandinavo contro gli svedesi padroni di casa, che per colmo di sfortuna erano toccati proprio a noi. Mancava una sola gara, contro la Francia, forse ci avrebbe eliminati, ma ce la saremmo giocata. Certo, la nostra non era più la nazionale della Danish dynamite, ma una squadra molto più operaia e sbrigativa, niente fronzoli e tanta corsa.
Frida aveva storto il naso a punta quando le avevo proposto di vedercela insieme. A lei piaceva il calcio-spettacolo e quelli, ripescati all’ultimo e buoni manovali della palla, non la seducevano. Era diventata ancora più… più… Frida, una bellezza strana, occhi sempre neri e profondi, ma con uno scintillio in meno ed un’ombra di attesa in più. Anche lei al gymnasium, ma non aveva ancora deciso cosa fare dopo. Le occasioni per vederci non erano tante, ma ormai era fisso che almeno un paio di volte al mese c’incontrassimo. Senza averlo programmato, era avvenuto automaticamente e ci bastava. Anche l’invito per la partita non era stato studiato, in quel momento mi andava di vederla insieme. Era un caso, come forse era per caso che lei avesse accettato. Punto. Sarebbe diventato un vero tiro mancino solo dopo aver pensato di farli incontrare. E, a differenza di Ole, Frida nemmeno sapeva che lo avrebbe rivisto. Già era tanto che non avesse rifiutato. Quegli aitanti taglialegna proprio non le facevano sangue.
Quando si sono ritrovati insieme nel salotto di casa mia il tempo è sembrato fermarsi. Frida non era nemmeno entrata che il campanello s’è messo a suonare di nuovo. Gli ha aperto proprio lei, forse si aspettava mia mamma (Frida la adorava) e s’è visto davanti Ole. Non ha mosso un muscolo, lo ha fatto entrare e, guardandomi di sbieco, con una smorfia tra il sorpreso di chi davvero non se l’aspettava ed il divertito di chi accetta una sfida, mi ha chiesto: “Le formazioni le hanno date?”. Anche stavolta, non so come, m’è scappato un “Simonsen non gioca” che ancora oggi, con moglie (che assomiglia a Frida) e figli, non mi riesco a spiegare. Sarà stato quel bene represso per anni che non poteva sciogliersi per entrambi allo stesso tempo, sarà stato che ormai non eravamo più ragazzini e la sfrontatezza giovanile restava pur sempre una medicina miracolosa in certe situazioni. Sta di fatto che Ole ha dapprima tossito come una vecchia locomotiva rugginosa, poi s’è accasciato sul divano ridendo senza freni. Frida, allora, scalciandogli leggermente la punta di un piede, com’era solita fare quando voleva tormentarti amichevolmente, gli ha domandato “Almeno adesso sei contento, stronzo?”.
Abbiamo vinto 2-1, Elstrup ci ha regalato un sogno a poco più di dieci minuti dal novantesimo, portandoci ai quarti, noi che nemmeno avremmo dovuto esserci. Il calcio, come la vita, è bizzarro, vinci quando meno te l’aspetti, basta un momento per rubare la felicità, rivedere tutto con uno sguardo diverso e sentirti al centro del mondo anche ad Aalborg. Era un banale mercoledì 17 giugno, ma sembrava domenica di Pasqua, la resurrezione di un’amicizia. O forse no. Quella non era mai morta, magari letargheggiava, aspettava l’occasione buona per risvegliarsi, quella giornata di metà settimana che, per noi, sarebbe diventata indimenticabile. Magari il nostro europeo sarebbe finito lì, nell’altro girone una tra Olanda e Germania, o magari entrambe, sarebbe andata avanti ed allora nemmeno Brian Laudrup, il fratello di Michael, avrebbe potuto compiere il miracolo. O forse no?… Ma a noi andava bene così, respiravamo la pace di un sorriso venuto su dal cuore. Il giorno dopo ci siamo rivisti tutti e tre, in piazza Nytorv, per noi il cuore del nostro mondo. Ole e Frida non la smettevano di mettermi in mezzo, “Hai visto? Anche il meno sveglio dei tre può inventarsi un colpo di genio”, mi dicevano dandomi di gomito uno a destra e l’altra a sinistra. Ridevano. Anche se, a vederli bene, sorridevano. E mai gli ho confessato che la battuta su Simonsen, che a loro sembrava una mia astuta trovata, studiata a tavolino da giorni, era, in realtà, figlia del caso, nient’altro. O forse no?
Alfonso Esposito (Castellammare di Stabia, 1968). Da giovane studia Giurisprudenza e scrive di calcio per la Gazzetta dello Sport. Avvocato penalista, ha curato per la rivista Calcio2000 la rubrica Ad un passo dalla gloria, dedicata alle promesse non mantenute del calcio. Ha pubblicato Napoli (Urbone Publishing, 2017) dedicato ai primi dieci bomber azzurri di sempre, e, Alla riscoperta dell’est (2019) sul calcio d’oltrecortina.